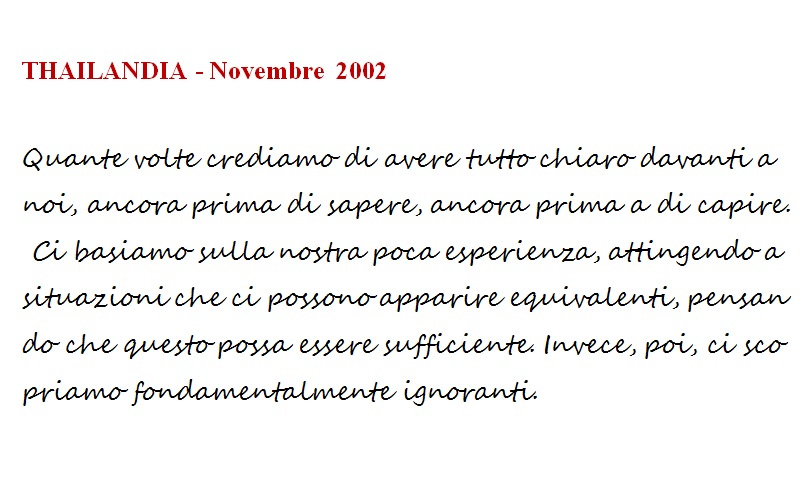
La decisione era stata presa. Da Chiang Rai, capoluogo del nord della Thailandia, avremmo effettuato degli spostamenti per andare alla scoperta delle popolazioni rurali della regione. Le aree di confine, quelle con il Myanmar e il Laos, risultavano ricche di quella componente umana che si esprime nella diversità.
Il Sig. Ritt, colui che ci accompagnava in questa esperienza culturale, ci avvisò della possibilità di fare visita a un villaggio Padaung, definito come un vero piatto forte per il turista. Rimanemmo perplessi, prima di tutto per l’idea turistica, in quanto i Padaung mi risultavano essere una etnia birmana e per quanto prossimi al confine ci dava l’idea di una forzatura. Accettammo, dopo tutto avremmo trovato il villaggio lungo la strada da percorrere. In effetti non trascorsero molti chilometri e il pick-up si fermò davanti ad un baracchino con un cartello che indicava, in modo incredibile, “Ticket Padaung village”.
La cosa ci lasciò ancora di più a bocca aperta: pagare un biglietto per visitare un villaggio. Accanto alla biglietteria due elefanti assonnati, da affittare per vivere l’emozione di raggiungere il posto sopra il loro dorso. Gli elefanti non ci interessavano affatto, ma senza un vero motivo, e forse perché tanto eravamo lì, accettammo di pagare il biglietto e quindi prendemmo a piedi il sentiero.
Il villaggio Padaung:
La camminata non fu lunga. Raggiungemmo un piccolo torrente, poi un ponticello ed entrammo in uno spiazzo quadrato con delle capanne semplicissime e apparentemente spoglie. Subito balzò ai nostri occhi l’estrema pulizia dello spiazzo, niente affatto tipica per un villaggio abitato e tanti ne avevamo visti durante il nostro viaggio in Thailandia. Inoltre, non c’era nessuno in giro, pareva disabitato. Come dal nulla spuntarono delle donne e alcuni bambini da un angolo nascosto.
Le donne, adorne dei loro ricchi abiti colorati e con i lunghi colli ricolmi di anelli, si misero in mostra sedendosi su delle panche con tettoia di canna. Ci sentimmo a disagio e quel loro mettersi in mostra ci offrì una strana sensazione di falso. Passeggiammo, quasi a fare finta di nulla, per vedere se anche loro avessero deciso di non considerarci. Infatti, dopo un po’, le donne si alzarono e andarono a svolgere delle piccole faccende. Nel frattempo commentavamo quanto osservato: la simulazione del villaggio, il loro mettersi subito in posa. Non avevamo le idee chiare e in quel frangente la valutazione era pervasa di stereotipi.
Seduti, su una di quelle panche coperte da la tettoia di canne, eravamo intenti nei nostri commenti dubbiosi, quando una giovane ragazza Padaung si avvicinò a noi cogliendoci alle spalle. Quell’arrivo ci trovò impreparati, non ci eravamo affatto accorti della sua presenza e rimanemmo un attimo interdetti. Lei invece ci sorrise e con naturalezza si mise a sedere accanto a noi.
La ragazza Padaung:
La ragazza aveva due occhi profondi come la tristezza che emanava il suo volto, un sorriso lieve come la cortesia riposta nei nostri confronti, il volto truccato come una maschera da porgere a dei visitatori. Un saluto nacque spontaneo, che lei ricambiò con un gesto amplificato dal lungo e rigido collo nascosto dai numerosi collari. Mia moglie si presentò, offrendogli la mano come ulteriore gesto di cortesia, la ragazza comprese pronunciando il suo di nome, che invero non sono affatto più in grado di ripetere.
Lei, comunque, parlava un inglese molto semplice, quanto bastava per farsi capire. Per noi divenne sufficiente, allo scopo d’instaurare un dialogo possibile. Le chiedemmo se viveva lì, in quel villaggio vuoto, e la sua risposta affermativa ci lasciò poco convinti. Insistemmo, chiedendo se dormiva proprio nel villaggio che vedevamo e lei, con semplicità, ci indicò la boscaglia: stavano nel villaggio solo durante il giorno e la cosa ci parve ancora più strana, ma non riusciva a spiegarci di più.
Spostammo la nostra curiosità verso la sua famiglia, a quel punto i suoi occhi si abbassarono. Genitori, parenti e suo marito erano in Myanmar, molti arrestati dal regime militare che perseguitava i Padaung in quel periodo. Lei era una rifugiata dalla repressione che subiva la sua etnia, o forse venduta in Thailandia, non riuscivano a cogliere il dettaglio esatto. Viveva sola, con la sua piccola bimba assieme ad altre donne nella stessa condizione. La piccola, bellissima e anch’essa con al collo un certo numero di anelli, giocava dietro di noi, non ci eravamo accorti nemmeno della sua presenza. Lei la chiamò, aiutandola a mettersi a sedere accanto a noi, e la mostrò con un dolce sorriso pieno di orgoglio materno e d’amore.
Le parole sono sempre un mezzo che avvicina la persone e in quel frangente si era creata una relazione, un rapporto che stava mutando il valore di quella visita. Proseguimmo nel nostro curiosare, ci sentimmo come autorizzati ad approfondire il loro vivere fra quelle capanne finte. I dettagli, che per noi erano incongruenti, generarono l’ingenuità della nostra domanda: se la vera casa si trovava nella boscaglia, cosa facevano nel villaggio dove ci trovavamo? La risposta, pur nella sua semplicità, ci stese peggio di un pugile peso massimo. Stavano lì ad aspettare i turisti… per le foto… per farsi vedere.
Aprire gli occhi:
Capimmo e ci svegliammo dal sonno del turista. Le sue giornate, e quelle delle altre donne, erano scandite dalle visite, in cui dovevano mostrarsi per ottenere una percentuale che le facesse vivere da rifugiate. Noi, intesi come turisti occidentali invece, nella nostra ottusità racchiusa dagli obiettivi delle macchine fotografiche, immaginiamo di vivere un momento pittoresco, la falsa idea di esotico da raccontare agli amici nelle nostre comode case. Ma lei, giovanissima e con una bimba a carico, pur nella rassegnazione andava avanti e la sua mente volava libera nella speranza, un giorno, di poter tornare con i suoi cari, di abbracciare il marito arrestato dai militari in Birmania, di essere una persona nella sua dignità. Scoprimmo che era giunta in Thailandia da non molto, anche se non volle raccontare in che modo, aveva solo la speranza di una sorte migliore.
Anche lei ci pose delle domande, volle sapere qualcosa della nostra vita. Accontentammo la sua curiosità, ma senza palesare l’enorme differenza fra la nostra e la sua esistenza. Solo banalità per noi e il suo sguardo diceva più di qualunque parola. In ogni caso non portava rancore verso i turisti, anzi eravamo il piccolo sostentamento per lei e per tutte le altre donne. Il pensiero ricadde sulla biglietteria, domandandoci quanto restava a tutte loro del biglietto che avevamo pagato.
La ragazza ci chiese di fare una foto assieme, forse un gesto più dovuto all’abitudine verso il turista pagante e non spontaneo, ma acconsentimmo e quella foto l’abbiamo ancora.
Silenziosi, oltreché pensierosi, lasciammo il villaggio. Ma forse sarebbe più corretto definirlo zoo. Non sto esagerando, proprio uno zoo come quelli presenti nei circhi di tanti anni fa, con le bestie rare in bella mostra. In gabbia, anche se all’occhio distratto potrebbe non essere sembrato. Ma sono solo donne. Donne sole, che non avevano altra prospettiva che una foto di un turista. Come pappagalli multicolori chiusi per il nostro piacere, vivevano docili, recluse nella condizione di soggetti da spettacolo, lontane ormai dalla loro vera casa, dalla loro vera vita.
